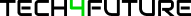Luci e ombre sulle materie plastiche bio-based: il fatto di essere di origine vegetale, dà loro, indiscutibilmente, la patente di biodegradabilità? Un lavoro dell’University of California San Diego sulle microplastiche di derivazione biologica offre lo spunto per alcuni chiarimenti e riflessioni sul tema.
Secondo la National Geographic Society, potrebbero trascorrere centinaia o migliaia di anni prima che la plastica, a livello globale, possa decomporsi completamente. Nel frattempo, è soggetta a un inesorabile processo di frammentazione in microplastiche e nanoplastiche. Processo conseguente non solo all’abbandono (involontario e volontario) di oggetti di plastica nell’ambiente, alle normali operazioni che riguardano il loro riciclo e alle pratiche di smaltimento in discarica, ma anche al trattamento delle acque reflue, alle perdite in mare durante il trasporto marittimo, all’usura dei pneumatici dei veicoli e al lavaggio di determinati tessuti sintetici, provocando contaminazioni diffuse nell’ambito degli ecosistemi terrestri e marini, con forti impatti negativi sugli organismi umani, animali e vegetali [fonte: “A Global Perspective on Microplastics” – Journal of Geophysical Research: Oceans, 2020].
Uno studio a cura dell’Ateneo coreano di Seoul [“Effects of microplastics on the terrestrial environment: A critical review” – Environmental Research, 2022], in particolare, insiste sulla pericolosità data dalle numerose interazioni delle microplastiche con il suolo:
«È stato dimostrato che le microplastiche entrano in contatto con un’ampia gamma di contaminanti, tra cui pesticidi, inquinanti organici, metalli pesanti e antibiotici e che fungono da vettore per il trasporto di tali sostanze. Inoltre, le microplastiche vengono veicolate anche attraverso le reti alimentari, con potenziali effetti dannosi sulla salute degli esseri umani e di altri organismi»
La soluzione è lavorare allo sviluppo di plastiche alternative, ispirate ai materiali esistenti in natura, a base vegetale, completamente e rapidamente biodegradabili nell’ambiente.
Ma la questione vera, centrale, ruota proprio attorno al concetto di “biodegradabilità”, al significato che le impongono le norme e gli standard vigenti nell’Unione Europea e alla struttura chimica dei materiali utilizzati in sostituzione di gas, petrolio e derivati, normalmente impiegati per la sintesi delle materie plastiche.
Se non si tiene conto di questi fattori, non si comprende come mai molteplici tipologie di plastiche a base biologica (dette anche “bio-based” o “bioplastiche”) oggi in circolazione, pur riducendo l’impronta di carbonio rispetto a quelle ottenute dal petrolio, non sono affatto biodegradabili. Il che ci riporta al punto di partenza.
Takeaway
Quando un materiale plastico è definibile “biodegradabile”?
Iniziamo col dire che, in chimica, un composto è soggetto a biodegradazione attraverso processi enzimatici ad opera di microrganismi presenti nell’ambiente (ad esempio, batteri o funghi), che lo trasformano in sostanze naturali (acqua, anidride carbonica o sali minerali) e lo immettono, così, nei cicli di madre natura.
Tra i principali riferimenti normativi atti a stabilire i requisiti in base ai quali un materiale plastico può essere definito “biodegradabile”, figura la UNI EN ISO 14855-1:2013 che, per la precisione, fissa gli standard europei per determinare la “biodegradabilità aerobica finale dei materiali plastici in condizioni controllate di compostaggio”, ossia la decomposizione del 90 per cento in almeno sei mesi, come da esito di regolare test di biodegradabilità.
Altri standard europei sono quelli fissati dalle norme EN 13432:2000 in tema di plastica compostabile per gli imballaggi e dalla UNI EN 14995:2007 per tutti gli altri tipi di prodotti di plastica. Tra le prerogative imposte dalle due norme, anche il superamento dei test di biodegradabilità (almeno del 90 per cento in sei mesi, come già accennato) e di disintegrazione, che deve avvenire dopo tre mesi e deve ridurre almeno il 90 per cento del materiale in frammenti di dimensioni inferiori a 2 millimetri.
Biodegradabilità: una questione di struttura chimica e non di origine dei materiali
A proposito di tempistiche relative a biodegradabilità e disintegrazione delle materie plastiche compostabili, un anno fa, fece un certo rumore un interessante lavoro congiunto, a cura dell’University of California San Diego e della Northwest University – “Not so biodegradable: Polylactic acid and cellulose/plastic blend textiles lack fast biodegradation in marine waters”, pubblicato sulla rivista scientifica PLOS One il 24 maggio 2023 – assai critico nei confronti di alcuni materiali compostabili in commercio, «cosiddetti “biodegradabili” anche se, per subire una rapida biodegradazione, richiedono condizioni specifiche, che possono essere raggiunte solo in ambienti industriali, a temperature elevate presenti negli impianti, e non naturali».
È il caso – illustrano gli autori – della nota e diffusa bioplastica compostabile a base di acido polilattico (PLA), derivata dagli zuccheri naturalmente presenti nel mais e nella barbabietola.
Ebbene, il team ne ha testato la biodegradabilità nelle acque marine, per mezzo di tessuti fabbricati con questa bioplastica, estendendo il test anche ai tessuti plastici a base di cellulosa e non biodegradabili a base di olio, giungendo a tali conclusioni:
«I risultati mostrano che l’acido polilattico non si degrada nell’ambiente marino per oltre 428 giorni. Ciò è stato osservato anche per il polipropilene a base di olio e il polietilene tereftalato, comprese le loro porzioni nei tessuti misti di cellulosa/plastica a base di olio. Al contrario, le fibre di cellulosa naturale e rigenerata subiscono una biodegradazione completa entro circa 35 giorni»
In un lavoro più recente, che vede protagonista lo stesso Ateneo di San Diego, [“Rapid biodegradation of microplastics generated from bio-based thermoplastic polyurethane” – Scientific Report, 12 marzo 2024], il gruppo di studio fa notare come il processo di biodegradazione, affinché si attivi, abbia bisogno che la struttura chimica del composto plastico contenga legami chimici che siano fisicamente accessibili agli enzimi con i quali operano i microrganismi.
Questo spiega perché, «sebbene molti materiali plastici a base biologica derivino da fonti naturali rinnovabili – come anche il biopolietilene e il biopolietilene tereftalato (bioPET), entrambi ricavati dalla canna da zucchero – questi possano potenzialmente persistere nell’ambiente a causa della loro limitata capacità di biodegradarsi in seguito a processi chimici che li rendono inaccessibili alla scissione biologica».
Sembra un paradosso, ma – sottolineano i ricercatori – è altresì possibile generare materie plastiche biodegradabili dal petrolio o da altre risorse fossili, proprio perché la biodegradazione è una proprietà chimica insita nel materiale piuttosto che una proprietà correlata al suo luogo di derivazione.
Focus sul poliuretano termoplastico bio-based
Nella ricerca di materie plastiche in grado di generare microplastiche dal ciclo di vita breve (di tre o sei mesi, non oltre), il già citato team dell’University of California San Diego si è focalizzato, in particolare, sui poliuretani, classe di polimeri impiegati nella produzione di numerosi articoli, tra cui adesivi, rivestimenti e cuscini in schiuma.
Più nel dettaglio, la scelta è ricaduta sul poliuretano termoplastico (detto anche TPU), una tipologia di elastomero caratterizzato da una sorta di mistura di gomma e plastica, che lo rende resistente e al contempo flessibile.
L’ipotesi di partenza formulata dal gruppo di lavoro poggiava sulla tesi secondo la quale un polimero come il poliuretano, con una struttura chimica data da legami esterei e uretanici, «ha il potenziale per una biodegradazione rapida e completa quando si consente all’attività dell’enzima idrolitico di procedere direttamente sul polimero».
Per provare questa ipotesi, sono stati effettuati due test, che hanno avuto come oggetto un materiale fatto di poliuretano termoplastico di origine biologica, ricavato sfruttando una materia prima rinnovabile come la biomassa di alghe.
L’obiettivo dei test era generare microplastiche frantumando il materiale plastico bio-based prodotto mediante il poliuretano termoplastico di origine biologica, per poi confermarne la rapida biodegradazione e la disintegrazione definitiva in condizioni di compostaggio domestico, ovvero di trasformazione della bioplastica in un prodotto utile, ad esempio, come fertilizzante per le piante di casa.
Risultati dei test di biodegradabilità (su suolo e in acqua) delle microplastiche ottenute
«La quantificazione delle particelle microplastiche ha indicato che le particelle di poliuretano termoplastico di origine biologica, sul suolo, si sono completamente degradate nell’arco di tempo di duecento giorni, mentre particelle simili originate da un polimero non biodegradabile, l’etil vinil acetato, non hanno mostrato alcuna riduzione del numero di particelle nello stesso lasso di tempo» hanno commentato i ricercatori.
La misurazione della produzione di anidride carbonica (conseguente ai processi enzimatici che, di fatto, rendono possibile la biodegradazione delle bioplastiche), derivata dalla trasformazione del poliuretano termoplastico di origine biologica in sostanza naturale, è avvenuta tramite uno strumento denominato “respirometro” – solitamene adoperato per quantificare l’ossigeno consumato dagli organismi vegetali – e ha confermato, in condizioni di compostaggio identiche, la biodegradazione e la mineralizzazione delle particelle di poliuretano termoplastico a base di alghe.
Riguardo, invece, alla biodegradabilità in acqua, il team ha osservato che «a intervalli di novanta e duecento giorni, quasi il 100% delle microplastiche a base di petrolio veniva recuperato, in quanto nessuna di esse si era biodegradata».
Al contrario, dopo novanta giorni, soltanto il 32% delle microplastiche a base di alghe è stato recuperato, dando evidenza al fatto che più di due terzi di esse erano state oggetto di biodegradazione. E dopo duecento giorni, soltanto il 3% è stato raccolto, a significare che ben il 97% si era completamente disintegrato.
Glimpses of Futures
Il lavoro descritto dimostra che adottare materie plastiche di origine vegetale, a impatto zero sull’ambiente, che si biodegradano in tempi rapidi se rilasciate sul suolo o in acqua, è un traguardo raggiungibile, ma a patto che ricercatori e produttori considerino due fattori imprescindibili: le proprietà chimiche del materiale prescelto e le condizioni ambientali alle quali lo si espone per biodegradarlo.
Relativamente a quest’ultimo punto, è importante andare oltre le alte temperature degli impianti industriali normalmente utilizzati per i test di biodegradazione. Lo abbiamo visto con la bioplastica ricavata dall’acido polilattico, «suscettibile all’idrolisi negli impianti di composizione industriale, ma non negli ambienti marini».
Le microplastiche generate da poliuretano termoplastico a base di alghe, invece, dagli esiti dei primi test in condizioni di compostaggio domestico, promettono di degradarsi rapidamente (e in alta percentuale) nell’ambiente e, dunque, di non costituire fonte di inquinamento per gli ecosistemi.
Avvalendoci, ora, della matrice STEPS, proviamo ad anticipare scenari futuri, valutando i possibili impatti che l’evoluzione della metodologia descritta per la ricerca e lo sviluppo di materie plastiche innocue per l’ambiente– in quanto di derivazione biologica – e, al medesimo tempo, rapidamente e completamente biodegradabili, potrebbe avere dal punto di vista sociale, tecnologico, economico, politico e della sostenibilità.
S – SOCIAL: è possibile, da qui a trent’anni, un mondo senza microplastiche che invadono i suoli e i mari, inquinando, di conseguenza, tutta la catena alimentare? Lo studio illustrato accende più di una speranza, foriera di uno scenario futuro in cui risorse fossili come gas, petrolio e derivati lasceranno completamente il posto, nella produzione di materie plastiche, a organismi vegetali che – punto nodale – saranno realmente biodegradabili, non solo nei forni industriali ma passando attraverso la trasformazione in acqua, anidride carbonica, sali minerali o in altre sostanze del tutto naturali, a opera di batteri e funghi presenti nell’ambiente e nei tempi stabiliti dalle normative di riferimento UE.
T – TECHNOLOGICAL: sotto il profilo metodologico e tecnico, l’avere coniugato un materiale specifico come il poliuretano termoplastico – resistente, flessibile e biodegradabile attraverso un’azione enzimatica diretta e non ricorrendo alle elevate temperature degli impianti industriali – e la biomassa algale, ha consentito al team di studio di raggiungere l’equilibrio tra elemento bio-based della plastica ottenuta e la sua completa e rapida disintegrazione nell’ambiente. I test futuri, però, dovranno prendere in esame condizioni di compostaggio in altri contesti oltre a quello domestico, per ampliare il respiro della ricerca e sperimentare ambiti naturali in cui la biodegradazione del poliuretano termoplastico a base di alghe potrebbe avere altri impatti in quanto a tempistiche e modalità.
E – ECONOMIC: a tendere, l’immissione, sui mercati globali, di bioplastiche “realmente” biodegradabili in tempi brevi, su suolo e in mare, cambierebbe del tutto la prospettiva economica dei mercati di riferimento, anche in vista di possibili, future, regolamentazioni in merito a sistemi di certificazione istituiti da autorità pubbliche. Attualmente, i dati 2023 sulla produzione globale di bioplastiche, resi disponibili dall’Associazione European Bioplastics, evidenziano una situazione assai rosea, destinata a evolvere ulteriormente, passando da circa 2,18 milioni di tonnellate prodotte nel 2023 a circa 7,43 milioni di tonnellate nel 2028. Ma la domanda che ci si pone, alla luce degli studi più recenti in materia, è se questi dati contemplino solo le bioplastiche aderenti agli standard di biodegradabilità, testate in ambiente naturale e non solo industriale, oppure se facciano riferimento a un unico calderone, in cui compare anche il più volte menzionato acido polilattico, biodegradabile solo in apparenza.
P – POLITICAL: dal punto di vista politico, l’impatto dato dall’avvento di bioplastiche dalla biodegradabilità testata e prevista nei tempi stabiliti dalle normative UE, si sta già facendo sentire. Il 17 gennaio 2024, infatti, il Parlamento europeo, con la Direttiva contro il greenwashing e le informazioni ingannevoli ai consumatori – in vigore dal 26 marzo 2024 e operativa dal 27 settembre 2026 – ha compiuto una scelta decisiva, quasi epocale, contro le dichiarazioni generiche da parte delle aziende, non supportate da prove concrete, a corredo dei prodotti in tema di ambiente e sostenibilità, tra cui, per l’appunto, l’aggettivo “biodegradabile”, così come le espressioni “a impatto climatico zero”, “rispettoso dell’ambiente” e altre locuzioni simili. Per porre fine alla pratica delle informazioni fuorvianti e supportare, invece, la scelta di informazioni corrette e veritiere da apporre sulle confezioni dei prodotti, in futuro verrà regolamentato l’uso dei cosiddetti “marchi di sostenibilità”, basati su certificazioni ottenute solo dopo un iter di test, prove e verifiche.
S – SUSTAINABILITY: il recente studio dell’University of California San Diego qui descritto, insieme a quello di un anno fa, da parte dello stesso Ateneo, sui materiali plastici di dubbia biodegradabilità, accendono i riflettori sulla necessità, in Europa, di una sostenibilità che non sia solo ostentata e pubblicizzata, ma certificata, provata, testata, da parte di quelle imprese che operano nei settori ambiente, ecologia, energia e green. Ricordiamo che il 2030, data ultima fissata dall’Agenda ONU per il conseguimento dei 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile, tra cui gli Obiettivi 14, sulla conservazione degli oceani, dei mari e delle risorse marine quali elementi fondamentali per la salute e la salvaguardia dell’intero pianeta, e 15, sulla protezione e promozione dell’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, non è lontano.