Il Web 3.0 non costituisce affatto una novità. Tuttavia, la sua popolarità ha vissuto una ribalta clamorosa nel corso del 2021, grazie al grande interesse scaturito nei confronti delle tecnologie blockchain, crypto, NFT e, più in generale, dell’immaginario di un web decentralizzato che possa costituire un’alternativa allo strapotere dei big tech del Web 2.0.
Tale scenario va inteso soprattutto nella condizione di sottrarre il controllo e lo sfruttamento dei dati dalle mani di pochi accentratori, grazie a nuovi modelli di business che incentivino gli utenti a valorizzarli in prima persona, grazie a dinamiche economiche in grado di sfruttare le tecnologie decentralizzate.
Per molti questa visione non andrebbe molto oltre quella di una suggestiva utopia, per altri si tratta semplicemente dell’unico futuro possibile per l’internet del domani. Ad oggi è praticamente impossibile fare previsioni sul fatto che il Web 3.0 possa imporsi, in quali termini e, soprattutto, con quali tempistiche. La sua sfida rappresenta in ogni caso un evento fondamentale nella storia della tecnologia ed andrà seguita passo dopo passo, comprendendone le logiche e la portata applicativa.
Cos’è il Web 3.0, la terza generazione del web
Non esiste una definizione univoca per quanto concerne il Web 3.0, in quanto rappresenta un termine ombrello per descrivere la terza generazione dei servizi internet per siti e applicazioni web. In realtà, il Web 3.0 ha vissuto due fasi molto distinte nella loro caratterizzazione, a distanza di diversi anni.
Nella sua definizione originale, il Web 3.0 è altrimenti noto come web semantico, o web intelligente, per via della sua configurazione data-driven, alimentata dai servizi cognitivi dell’Intelligenza Artificiale, secondo le intenzioni dello stesso Tim Berners-Lee, il creatore del World Wide Web, circa vent’anni fa.
Più recentemente, l’intenzione di trovare un’alternativa concreta al web attuale, fortemente centralizzato, ha dato luogo al Web3, i cui concetti non escludono ma si differenziano in maniera piuttosto evidente rispetto alla definizione originale del Web 3.0. Il Web3 è infatti stato coniato nel 2014 da Gavin Wood, fondatore di Polkadot, come web decentralizzato e basato su tecnologie come blockchain, crypto e NFT.
Il Web3, pur basandosi su un paradigma differente, ha rilanciato le ambizioni del Web 3.0, sui cui presupposti originali era da tempo scemato l’entusiasmo. Oggi i due termini vengono utilizzati quali sinonimi persino nello statuto di Web3 Foundation, ragion per cui, onde evitare ambiguità, faremo sempre riferimento al termine Web 3.0.
Il Web 3.0, ancor prima di capire cosa voglia diventare dal punto di vista applicativo, ha ben chiaro cosa fare da grande. Il suo obiettivo dichiarato è quello di contrastare la supremazia degli shareholder del social web in funzione di un internet più user-centric.
Il Web 3.0 vede coinvolta un’ampia varietà di tecnologie, come possibile risultato delle convergenza di blockchain, NFT (Not Fungible Token), crypto (DeFi), Intelligenza Artificiale, realtà aumentata, realtà virtuale e big data & analytics con le risorse IT disponibili grazie al cloud computing.
Grazie a queste tecnologie, l’originale utopia del Web 3.0 avanza quanto meno allo step di sogno possibile. L’obiettivo diventa quello di creare un’economia decentralizzata, aperta e permissionless, le cui applicazioni sono progettate in maniera user-centric.
In altri termini, anziché foraggiare puntualmente gli shareholders dei servizi centralizzati, illudendosi che sia tutto gratis, come accade nel Web 2.0, gli utenti diventerebbero in grado di guadagnare grazie alla loro presenza e alle loro attività online. Internet acquisirebbe una dimensione più equa ed inclusiva. Sarebbe un luogo migliore in cui vivere le nostre esperienze online.
È evidente come il Web 3.0 non rappresenti al momento un corpus alternativo all’attuale World Wide Web, ma la sommatoria di più applicazioni distinte, ispirate da presupposti decentralizzati, sia dal punto di vista del design che delle tecnologie utilizzate per svilupparlo.
La ultra-trentennale storia del web, da Tim Berners-Lee al metaverso
La prima rete di computer della storia è stata ARPANET, creata da DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) negli anni Settanta, come progetto della difesa americana dotato di un protocollo host-to-host e un software di rete che consentiva ai vari computer connessi di comunicare tra loro ed utilizzare pionieristiche applicazioni di posta elettronica.
Nessuno all’epoca poteva immaginare che la mail sarebbe diventata una delle principali applicazioni di internet, né uno strumento di comunicazione tanto potente e diffuso, così come ARPANET non era una rete concepita per essere accessibile dal grande pubblico. Il suo modello fu di grande ispirazione per le generazioni che seguirono, già a partire dagli anni Ottanta.
La nascita del web come lo intendiamo oggi viene universalmente attribuita a Tim Berners-Lee, ricercatore del CERN di Ginevra, a cui si deve il concept del WWW (World Wide Web), espresso attraverso tre tecnologie fondamentali: il linguaggio semi-strutturato HTML (HyperText Markup Language), l’URL o URI (Uniform Resource Identifier) e il protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol).
Era il 1991, quando Tim Berners-Lee ha messo online la prima pagina web, dando di fatto inizio ad una nuova era nella tecnologia delle comunicazioni. Il Web 1.0 era nato e di lì a breve avrebbe letteralmente cambiato il corso della storia.
Sia ARPANET che il World Wide Web sono nati dalla ricerca, non in un contesto commerciale e questo ha favorito la diffusione di standard tecnologici condivisi, come il TCP-IP, il DNS e lo stesso HTTP / HTTPS che vengono tuttora utilizzati per consentire la navigazione sul web.
Il web è nato e si è diffuso con una interoperabilità e degli open standard che sono stati supportati nella loro evoluzione tecnologica dal consorzio W3C. Come vedremo, il web decentralizzato sta provando a ripercorrerne le orme sfruttando differenti tecnologie, ma ad oggi non è riuscito ad imporre alcuno standard tecnologico, né ad attirare attorno a sé il consenso e la volontà necessaria per riuscire in un’impresa per molti versi titanica.
Per fare ordine e comprendere al meglio l’attuale scenario evolutivo del Web 3.0, è necessario ripercorrere le tappe che lo hanno in qualche modo preceduto, coinvolgendo nella narrazione anche il Web 1.0 e il Web 2.0 a cui il Web3, cui si deve la riscoperta del Web 3.0, sta cercando con tutte le sue forze di proporsi come l’alternativa necessaria per riportare il controllo della rete nelle mani degli utenti.
La storia del web è un enorme volume di pagine che si trascina ormai da oltre trent’anni, un lasso di tempo in cui è cambiato per sempre il nostro modo di lavorare, comunicare e vivere nella società.
Web 1.0: decentralizzato e rivoluzionario, ma limitato nell’interazione
Nei primi anni Novanta si sono diffuse le prime pagine web e i browser sviluppati per consentire agli utenti connessi ad internet di visualizzarle. La navigazione, oltre che dalla digitazione dell’URL del sito prescelto, era consentita dagli hyperlink, collegamenti ipertestuali che consentono tuttora di collegare tra loro più pagine web ed accedere ai contenuti multimediali.
Il Web 1.0 si basava quasi esclusivamente sul linguaggio HTML, capace di istruire nel dettaglio il browser in merito al caricamento e al rendering dei contenuti delle pagine web. Una tecnologia semplice, ma al tempo stesso piuttosto limitata. I contenuti delle pagine web erano infatti di natura statica e le potenzialità multimediali erano nativamente vincolate da connessioni ad internet molto limitate in termini di banda e velocità.
Nonostante ottime idee, più di tanto non era possibile ottenere. Mancavano ancora le tecnologie per farlo. A farne le spese era soprattutto l’esperienza utente. Bisognava ottimizzare il più possibile anche la più semplice delle immagini, ricorrendo inoltre a stratagemmi come il loro caricamento progressivo. Intere generazioni di web designer si sbizzarrirono a suon di pagine HTML infarcite, con estrema moderazione, di immagini in formato JPG e TIF.
Anche se i risultati di sforzi immani producevano siti web che, visti oggi strapperebbero nella migliore delle ipotesi un bel sorriso, il Web 1.0 coincise con l’inizio dell’utilizzo di internet per comunicare su scala globale. La portata di tale innovazione fu a dir poco rivoluzionaria e dirompente, in quanto generò una decentralizzazione ed una democratizzazione delle informazioni senza precedenti nella storia. Con un semplice modem 56k domestico chiunque poteva connettersi ad internet ed esplorare contenuti pubblicati in tutto il mondo, scrivere mail e spedire file. Le chat e i newsgroup consentivano di condividere le informazioni con gli utenti con cui si condivide un interesse per un argomento specifico. Tutto era incredibilmente statico e testuale, ma lasciava presagire a potenzialità incredibili, che si sono in seguito avverate ben oltre le più rosee aspettative.
Attraverso il web era finalmente possibile contattare persone che altrimenti non avremmo mai potuto incontrare o venire a conoscenza di informazioni che non avremmo mai potuto conoscere. Internet ha consentito per la prima volta di abbattere le barriere del tempo e dello spazio. Un vizio che sarebbe diventato ben presto un’abitudine, grazie alla diffusione dei sistemi mobile e delle tecnologie emergenti.
Oggi un mondo senza internet sarebbe impensabile, semplicemente impossibile. Eppure parliamo di un fenomeno che ha da poco compiuto i primi trent’anni di vita, che diventano molti meno se pensiamo ad un’implementazione davvero mainstream del web.
Web 2.0: l’era dei social network e della centralizzazione di Facebook, Google e Amazon
Se il Web 1.0 ha monopolizzato la scena negli anni Novanta, attraverso il canonico percorso del Hype Cycle delle tecnologie emergenti, gli anni Duemila hanno contrassegnato il rilancio e la consacrazione del web.
La data iconica, quella da segnare sul calendario, è il 15 gennaio 2001, quando Jimmy Wales e Larry Sanger aprirono la prima edizione di Wikipedia, la prima e tuttora più diffusa enciclopedia online, libera e collaborativa, a cui ogni utente può offrire il proprio contributo in termine di informazioni. In un colpo solo, Wikipedia ha portato sul web il fenomeno dei contenuti generati dagli utenti, un’azione corale di conoscenza bottom-up, che genera valore grazie all’intelligenza collettiva.
Il web iniziava ad essere interattivo. Da una fruizione puramente passiva della rete, risultato di milioni di pagine web statiche, stava diventando possibile inserire dati a supporto di applicazioni create da altre persone. Lo è stato nel caso dei blog (sintesi di web log), una sorta di diario personale in cui gli utenti possono tuttora pubblicare contenuti in merito ad uno o più argomenti, in grado di suscitare interesse nei confronti di altre persone, che possono interagire attraverso i commenti ai post.
Considerazioni analoghe potrebbero essere spese per i forum di discussione, contenuti durevoli e capaci di catalizzare community attorno a specifici temi di interesse. Al tempo stesso, le reti peer-to-peer hanno consentito di condividere in maniera più o meno lecita i file attraverso internet, direttamente dai computer degli utenti connessi a servizi come eMule o Torrent, senza ricorrere ad alcun server centralizzato.
Tale dinamica ha stravolto per sempre l’industria dell’entertainment, rendendo di fatto possibili i modelli di business dei servizi on-demand come iTunes, Shopify e Netflix.
Il potere di Google nella ricerca dei contenuti sul web
Ben presto i blog sono diventati tra i principali canali di comunicazione anche in ambito aziendale, affiancando il tradizionale sito web. I blog aziendali sono diventati strumenti fondamentali per il posizionamento sui motori di ricerca e il coinvolgimento della community, la base utenti da cui trarre profitto grazie al consolidamento della relazione con il brand. I motori di ricerca della prima generazione hanno ben presto lasciato spazio al motore di ricerca per eccellenza: Google.
Lanciato nel 1997 da Sergey Brin e Larry Page, Big G è diventato di gran lunga il sito più visitato al mondo, come motore di ricerca per i contenuti sul web. Oltre a catalogare e indicizzare le risorse del World Wide Web, Google Search garantisce servizi di gestione portfolio fotografico, newsgroup, notizie (Google News), mappe (Google Maps), e-mail (Gmail), shopping, traduzioni e molto altro, se consideriamo altri brand acquisiti nel frattempo, come il celeberrimo Youtube per i contenuti video generati dagli utenti. Alphabet, holding che fa capo a Google, vanta ormai un ecosistema sconfinato di tecnologie e servizi che superano ampiamente i confini del web.
Senza girarci troppo attorno, se oggi il tuo business non appare nelle SERP (Search Engine Results Pages) di Google, è come se non esistesse. Questo ha portato alla diffusione di una disciplina fondamentale per quanto concerne la creazione e la gestione dei contenuti sul web (Content Creation e Content Management), ossia la SEO (Search Engine Optimization), che oltre a possedere una natura tecnica, atta ad accattivarsi le simpatie degli algoritmi di Google, costringe chi scrive i contenuti a rispettare regole ben specifiche.
Google impone le regole, i creatori di contenuti o le rispettano o finiscono per risultare penalizzati nel raggiungere il loro pubblico di riferimento, da cui dipende ovviamente la fortuna del business stesso.
La nascita dei social network del Web 2.0: Facebook e i suoi fratelli
Un altro fenomeno dirompente del Web 2.0 è stata la diffusione dei social network. Il primo social in assoluto, Sixdegrees, ha visto i propri natali nel 1996, ma soltanto nel 2004, grazie all’arrivo di Facebook, il fenomeno più coinvolgente della rete ha iniziato ad essere preso davvero sul serio.
La “creatura” di Mark Zuckerberg ha riscosso un successo senza precedenti, con una rapidità senza precedenti. Miliardi di utenti in tutto il mondo utilizzano ogni giorno Facebook per condividere contenuti da loro creati.
Oltre a Facebook, il portfolio social di Zuckerberg dispone anche di Instagram e Whatsapp, risultato delle rispettive acquisizioni miliardarie, e di Oculus, che sarebbe diventato il virtual reality brand della nuova holding che guarda al metaverso. Oltre ai social Network della holding Meta, ritroviamo valide e diffuse alternative come Twitter, attualmente al centro di una controversa acquisizione da parte di Elon Musk, Linkedin, il social business acquisito da Microsoft, Twitch, TikTok, Snapchat, Pinterest, Reddit, Telegram, Tinder e molti altri.
L’unica regione demograficamente molto rilevante nel mondo rimasta esclusa dal dominio dei citati social network, per ragioni di carattere strettamente politico, è stata indubbiamente la Cina, che ha in ogni caso sviluppato i propri canali alternativi, al fine di non rendere disponibile il controllo dei dati della propria popolazione ai big tech statunitensi.
L’e-commerce su scala globale: l’implacabile strapotere di Amazon
L’era del Web 2.0 ha visto la prepotente affermazione dell’e-commerce, passato dall’essere un complemento accessorio al costituire il punto nodale delle strategie retail delle aziende di prodotto. Oltre agli e-commerce proprietari, disponibili sui canali ufficiali di un brand, si è assistito alla crescita esponenziale dei marketplace, siti esclusivamente dedicati alla vendita sul web in cui è possibile trovare prodotti appartenenti a diverse categorie merceologiche. Un nome su tutti: Amazon.
Oggi se uno deve acquistare qualcosa online, pensa immediatamente ad Amazon, non utilizza nemmeno Google per effettuare la ricerca. Andrà direttamente su Amazon. Certo di trovare qualsiasi cosa, ad un prezzo mediamente buono grazie ad algoritmi capaci di allineare i prezzi sulla base di quelli più bassi disponibili in rete nelle regioni di competenza. Il tutto con le migliori condizioni logistiche e il miglior servizio clienti ad oggi disponibile. Amazon non ha rivali e ha costretto alla rapida obsolescenza molti modelli di business che lo hanno preceduto in ambito commerciale.
Amazon incarna inoltre alla perfezione la concezione di un modello basato sui servizi, dove le vendite nel marketplace costituiscono soltanto la punta dell’iceberg. Una volta acquisita una base utenti miliardaria, la società che fa riferimento a Jeff Bezos ha iniziato ad offrire una serie di servizi sempre più capillari e coinvolgenti, diventando un competitor diretto per tutti i principali fornitori di contenuti in streaming on-demand. E via dicendo, fino ai viaggi nello spazio e agli elisir di lunga vita, per cui occorrerà avere ancora un po’ di pazienza. Ma arriveranno.
Web 3.0: dal web semantico alla rinascita nel Web3

Se il Web 1.0 aveva rivoluzionato il modo di comunicare decentralizzato l’informazione e rendendola soprattutto democratica, il Web 2.0 ha segnato un’evoluzione per certi versi negativa, portando alla creazione di pochi colossi che vantano un potere praticamente assoluto sul controllo del traffico di dati sul web. Gli stessi vantano ormai uno strapotere economico senza eguali nella storia della tecnologia, con numeri in grado di mettere in crisi anche la forza economica di interi stati sovrani.
La volontà di cercare un modello alternativo è stata pressoché spontanea, se pur proveniente da situazioni che non potevano minimamente competere con la forza economica e tecnologica dei padroni del Web 2.0. Questa concezione è tuttavia quella che abbiamo già descritto in relazione al Web3, basato sulle tecnologie decentralizzate della blockchain. Tuttavia, c’è stata una fase pregressa, nota nello specifico come il web 3.0 inteso quale web semantico.
Anche se oggi non se ne parla praticamente più, il primo Web 3.0 è stato quello coniato, ancora una volta, da Tim Berners-Lee, una visione che prospetta il web come un immensa fonte di dati governata da applicazioni intelligenti, in grado di comprendere il contesto cognitivo per analizzare i dati stessi e prendere decisioni puntuali.
Il Web 3.0 di Tim Berners-Lee non si sarebbe in alcun modo limitato all’impiego di determinate parole chiave da inserire in un motore di ricerca, grazie alla capacità dell’Intelligenza Artificiale di assumere un ruolo attivo a supporto della navigazione.
La visione di Tim Berners-Lee è confluita nel progetto di ricerca Solid del MIT. Solid è l’acronimo di Social Linked Data e si pone quale obiettivo quello di fare sì che le persone possano rientrare gradualmente in possesso dei dati di navigazione che abitualmente cedono senza troppe cautele ai servizi gratuiti del Web 2.0.
La finalità scientifica della ricerca risiede nell’individuazione di metodi e tecnologie in grado di risolvere i cronici problemi di privacy e sicurezza che attualmente affliggono la navigazione sul web. Il progetto Solid vanta un gemello commerciale, Inrupt, creato da Tim Berners-Lee per permettere agli utenti di monetizzare grazie alla loro attività sul web.
Si tratta delle stesse logiche sui cui si basano i metaversi decentralizzati, che grazie al play-to-earn permettono agli utenti di guadagnare in funzione dell’impegno che dimostrano nel fruire delle esperienze disponibili all’interno dei loro mondi virtuali.
Il denominatore comune di qualsiasi punto di svolta rispetto al Web 2.0 risiede nella decentralizzazione, l’unico modello in grado di garantire che il potere e la disponibilità dei dati rimanga nelle mani delle persone, senza il rischio di una pericolosa deriva centralista, in cui uno soltanto guadagna a discapito dei legittimi creatori e proprietari dei dati stessi.
Il Web 3.0 di Tim Berners-Lee ha dato inconsapevolmente lo spunto ideologico per il web decentralizzato basato sulla blockchain, mentre gli aspetti semantici, basati sull’Intelligenza Artificiale, sono stati largamente sviluppati nel contesto del Web 2.0 per rendere sempre più efficienti i servizi dei big tech. Questo aspetto ha causato al tempo stesso una certa perdita di interesse nei confronti del Web 3.0, dal momento che molti dei benefici prospettati sono stati nel frattempo garantiti dallo stesso Web 2.0. La rinascita ideologica ha invece trovato pieno riscontro tra i sostenitori del Web3 e, più in generale, dal popolo della blockchain e delle crypto.
Il nuovo Web 3.0: la decentralizzazione come punto di rottura
Il web 2.0 ha provocato una centralizzazione dei dati così potente da apparire sostanzialmente irreversibile, al punto che si cerca di porvi rimedio a partire dalla generazione successiva a quella che stiamo vivendo.
Secondo alcuni dati pubblicati all’inizio del 2022 dal World Economic Forum, Google controlla attualmente l’87% delle ricerche sulla rete, mentre Meta può contare su oltre 3,6 miliardi di utenti unici, registrati sui vari social network della holding, in particolare Facebook, Instagram e Whatsapp.
Si tratta di cifre prossime al monopolio assoluto, e la cosa non sorprende se consideriamo come, già nel 2019, il 43% del traffico totale sul web fosse concentrato soltanto sui servizi di realtà come Google, Amazon, Meta, Netflix, Microsoft e Apple.
Secondo una ricerca sulle cinquanta maggiori compagnie al mondo nel 2021, pubblicata da Visual Capitalist nel novembre 2021, ben diciotto basano il loro business in larga prevalenza sui dati digitali, mentre soltanto tre fanno parte di un’industria consolidata come l’oil and gas, giusto per offrire la percezione di come i tempi siano drasticamente cambiati.
Nell’era della trasformazione digitale, i dati si avviano a diventare sempre più la principale fonte di ricchezza per chi ne dispone ed è in grado di analizzarli secondo finalità squisitamente speculative. Non c’è ragione di dubitare del fatto che, nel corso dei prossimi anni, i business basati sui dati sapranno incrementare ulteriormente la loro già enorme ricchezza.
![Web 3.0 - La storia del Web - Le fasi di passaggio dal Web1 al Web3 e le caratteristiche dell'economia dell'informazione, dell'economia delle piattaforme e dell'economia dei Token [credits: Shermin Voshmgir - autrice del libro "Token Economy - Token Economy: How the Web3 reinvents the Internet", Copyleft 2020]](https://tech4future.info/wp-content/uploads/2022/06/Web-3.0-Dal-web-1-al-web3-831x1024.jpeg)
Il controllo dei dati e il potere dei big tech, oltre il business molti dubbi di natura etica
Il fatto, universalmente noto, è che pochi grandi colossi oggi controllano la maggior parte dei dati presenti sulla rete, dinamica in costante crescita grazie alla rapida escalation del cloud computing, i cui maggiori provider corrispondono, ancora una volta, ad Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud.
Ma cosa accade a questi dati? La domanda è d’obbligo quando i tempi che verranno ci proietteranno in un’esperienza sul web sempre più immersiva, come quella del metaverso.
La centralizzazione dei dati costituisce e costituirà un problema enorme per la società, soprattutto per il fatto che i governi non sono ancora riusciti a limitare in maniera efficace lo strapotere dei big tech, soprattutto a fronte di condotte discutibili dal punto di vista etico, prima ancora che normativo. Il controllo che i big tech fanno dei dati acquisiti dai loro utenti spesso viola evidentemente la loro privacy e, nei casi più critici, la loro libertà.
Casi come Cambridge Analytica, che ha coinvolto direttamente Meta, così come la pubblicazione dei Facebook Papers, hanno documentato in maniera evidente come i dati degli utenti vengano utilizzati dai big tech con una condotta decisamente spregiudicata, con la sola finalità di trarre il maggior profitto possibile.
Le big tech hanno teso una “trappola perfetta” a miliardi di utenti che si sono illusi di godere gratuitamente dei servizi da loro offerti, ignorando, o avendo scarsa percezione delle conseguenze che il controllo dei dati immessi puntualmente comporta.
Appare curioso osservare quelle persone che si scandalizzano di fronte ad una notizia di cronaca relativa ad una possibile violazione della privacy. Per il solo fatto che stanno commentando la notizia su un social network hanno in realtà offerto il loro espresso consenso ad una cessione di dati personali e comportamentali che finiscono per alimentare sempre più il potere di pochi a discapito della libertà di molti, soprattutto in prospettiva futura. Certo, i social network sono incredibilmente coinvolgenti e comodi da usare, ma il prezzo da pagare è inconsapevolmente molto elevato.
In molti casi, i social diventano l’unico canale di business per determinate professioni, così come Amazon potrebbe diventare l’unico luogo in cui è possibile acquistare un certo prodotto. Cosa potrebbe accadere nel caso di un ban? Decisioni unilaterali ed arbitrarie possono condizionare e discriminare pesantemente la vita delle persone.
È accaduto all’artista australiana Thea-Mai Baumann, che ha visto cancellato da un giorno all’altro il proprio seguitissimo account su Instagram, per il semplice fatto che si chiamasse @metaverse, un handle che Meta ha giudicato sconveniente a seguito del proprio rebranding. Molti anni di lavoro per costruire una reputazione sono semplicemente andati in fumo in un singolo istante, senza ricevere alcuna risposta da parte del supporto ufficiale di Instagram.
Grazie alla sua determinazione e alla sua crescente notorietà, la Baumann è riuscita a catturare l’attenzione del New York Times, che ha perorato la sua causa chiedendo a sua volta spiegazioni a Meta. Temendo ulteriori ripercussioni da parte dell’opinione pubblica americana, la holding di Zuckerberg ha ripristinato l’account dell’artista australiana, liquidando quanto in precedenza avvenuto come “incorrectly removed for impersonation”, ossia la situazione che si crea quando un utente finge di essere qualcun altro o di impossessarsi in maniera illecita dell’identità di qualcun altro.
Questo episodio è parso sin da subito emblematico sul potere che i servizi centralizzati hanno sulle sorti delle persone, assolutamente impotenti, o quasi, di fronte a decisioni che il più delle volte sono prese da algoritmi automatizzati per gestire enormi flussi comportamentali, per accertarsi che rispettino policy anche del tutto legittime. A differenza di quanto accaduto alla Baumann, nella maggior parte dei casi gli errori avvengono in assoluta buona fede, ma non sono assolutamente semplici da rimediare e gli utenti si ritrovano ad affrontare una situazione molto penalizzante, in maniera del tutto impari.
Mark Zuckerberg, com’è ampiamente noto alle cronache, ha rinominato Facebook in Meta e, non più tardi del 28 ottobre 2021, ha affermato che la privacy e la sicurezza sono due valori assolutamente fondamentali e lo saranno ancora di più nel metaverso. Nel frattempo, Facebook continua a controllare i dati comportamentali dei suoi utenti come ha sempre fatto in passato e ad analizzarli sempre meglio grazie al continuo miglioramento degli strumenti di analisi predittiva, basati su algoritmi di Intelligenza Artificiale.
La ragione per cui molti non credono alle promesse di Zuckerberg è stata confermata dal fatto che, nello scorso mese di febbraio, Meta ha minacciato di cessare la disponibilità di Facebook e Instagram sul vecchio continente, qualora l’Europa, nel contesto di una revisione integrale del proprio quadro normativo sulla sovranità dei dati, avesse impedito di processare i dati acquisiti in Europa sui data center statunitensi che erogano i servizi analitici. Molti hanno visto in questa minaccia una palese ammissione di responsabilità.
La disputa è più che mai aperta, ma nel frattempo il tempo scorre e gioca come sempre a vantaggio dei big tech, abilissimi nello sfruttare le zone grigie delle normative per dare luogo a quella situazione di far west che consente loro di fare letteralmente il bello e il cattivo tempo. Meta non è ovviamente la sola company che abusa deliberatamente dei dati acquisiti dai suoi utenti, anzi, probabilmente costituisce a malapena la punta dell’iceberg.
Dopo aver dato per persa la seconda generazione del web, i sostenitori del web 3.0 si sono posti quale imperativo categorico quello di cambiare rotta guardando al futuro, cercando di impedire che la prossima generazione del web subisca la stessa sorte, con conseguenze ancor più critiche rispetto alla situazione attuale.
Il Web 3.0 e la missione di restituire alle persone il controllo dei loro dati
Il Web 2.0, come abbiamo analizzato nel corso dei precedenti paragrafi, ha creato una Internet centralizzata, chiusa ed estremamente proprietaria, nella direzione di diventare una vera e propria attività estrattiva di dati da cui generare profitto.
La percezione dei rischi che il monopolio sul controllo dei dati genera a livello socio-economico su scala globale ha innescato un sentimento di diffusa reazione, identificando nel Web 3.0 la condizione ideale per restituire alle persone il controllo dei loro dati e la dignità di una consapevole presenza online.
L’obiettivo è quello di evitare che, in una condizione incredibilmente immersiva come quella che si prospetta nel metaverso, l’attuale situazione possa degenerare in una sequenza distopica come quella che ci viene da tempo offerta dall’immaginario sci-fi e dalle visioni di futuro, in cui il controllo delle masse assume proporzioni totalizzanti.
Il Web 3.0 è quindi molto più di una semplice evoluzione tecnologica, in quanto comporta un autentico e radicale cambio di paradigma, in favore della più assoluta decentralizzazione. Le tecnologie devono pertanto risultare strumentali alla realizzazione di applicazioni capaci di supportare per davvero questo cambiamento. La blockchain è apparsa sin da subito congeniale ad assumersi questa responsabilità, essendo di fatto decentralizzata e peer-to-peer per design.
Web 3.0 vs Web 2.0: una coesistenza forzata
Al momento il Web 3.0 appare come una grande promessa, persino tutt’altro che semplice da mantenere. Le sue applicazioni crescono e cresceranno ulteriormente nei prossimi anni, ma non è pensabile, almeno nel breve periodo, che possa configurarsi una situazione in cui il Web 3.0 rimpiazzi il web come attualmente lo conosciamo e in cui viviamo quotidianamente le nostre esperienze online.
Un web a tutti gli effetti decentralizzato, in cui tutte transazioni verrebbero registrate su blockchain pubbliche, non è semplicemente fattibile a livello di risorse IT. Servirebbero disponibilità infinitamente superiori rispetto a quelle attualmente disponibili. Ne riparleremo molto probabilmente quando saranno disponibili i computer quantistici.
I più attenti potrebbero rilevare come la decentralizzazione di un servizio non debba per forza avvenire per mezzo di una blockchain pubblica, con l’enorme dispendio legato alla conservazione di tutte le transazioni effettuate da tutti gli utenti. Ci sono già diverse applicazioni che prevedono che ogni utente abbia una sorta di blockchain privata, che non condivide con nessun altro. La comunicazione di molte blockchain personali è una soluzione interessante, ma tecnicamente molto complessa quando si tratta di mettere in relazione le informazioni contenute dai vari registri privati. Per farla breve, diventa difficile ipotizzare che un simile metodo possa del tutto prescindere da una componente di tipo centralizzato.
Nell’ambito dei social network ci sono diverse soluzioni decentralizzate. Alcuni emuli di Facebook, come Planetary o Scuttlebutt, altri che si ispirano dichiaratamente a Twitter, come nel caso di Mastodon, una app di microblogging anche particolarmente diffusa. Twitter stesso ha implementato il progetto parallelo Bluesky, basato su un modello decentralizzato.
Il social decentralizzato rischia però di avere più punti di attrito rispetto agli indubbi benefici in materia di trasparenza e privacy. Un aspetto critico è dato dal controllo sull’utenza e sul contenuto, se si esclude un sistema di controllo centrale in grado di fungere da moderatore super partes, per quanto non possa mai risultare del tutto disinteressato. Un social autogestito può diventare molto pericoloso in termini di community, generando episodi di illegalità complessi da rimediare. Non esiste mai una soluzione univoca a tutti i problemi ed affrontare scenari inediti con la prospettiva di uno scarso controllo sulle dinamiche non incentiva in molti casi ad investire nella sua ricerca.
Il Web 3.0 non è infatti decentralizzato per natura. Le vie da percorrere saranno molte e saranno certamente esplorate negli anni a venire, continuando a trovare la soluzione in applicazioni specifiche, tante esperienze Web 3.0, in grado di popolare la rete come avviene nel caso del Web 2.0. Semplicemente assisteremo all’egemonia dei servizi decentralizzati e ad una crescente disponibilità di alternative decentralizzate.
Questa “sfida” appare decisamente evidente quando si parla di metaverso. Da un lato, ancora una volta Meta si propone come IL metaverso sociale di riferimento, ma non sarà certamente l’unico attore presente sulla piazza. Vediamo già ora la presenza di altri metaversi centralizzati, come Fortnite o il celebre Roblox, oltre ad una serie di mondi virtuali decentralizzati, come Decentraland, The Sandbox o Somnium Space, in cui la proprietà del metaverso non è riconducibile al proprietario del brand, ma ai legittimi proprietari degli appezzamenti virtuali che compongono la mappa complessiva.
Si tratta di modelli di metaverso agli antipodi, simili a livello visuale nell’interfaccia di un mondo virtuale in 3D, che si basano tuttavia su logiche economiche diametralmente opposte. Quale avrà successo? Oggi è del tutto impossibile fare previsioni fondate. Manca del tutto uno storico di riferimento. I metaversi centralizzati partono logicamente avvantaggiati, ma il potenziale dei metaversi decentralizzati è certamente superiore. Si pensi ad esempio alla capacità di attirare investimenti del virtual real estate, che consiste nella compravendita di terre virtuali all’interno dei vari metaversi decentralizzati.
La partita Web 2.0 vs Web 3.0 è assolutamente aperta e non è detto che debba esserci per forza un vincitore. Assisteremo a lungo alla convivenza di applicazioni e servizi basati su entrambi i modelli.
I pro e i contro del Web 3.0: l’ampio fronte delle critiche
Il Web 3.0 non ha mai mancato di suscitare perplessità e scetticismo da parte di un pubblico estremamente eterogeneo. Oltre ai fautori del Web 2.0, che logicamente ostracizzano la diffusione di un modello alternativo, molto pericoloso per i loro monopoli, ci sono diversi detrattori che, pur ritenendo auspicabile la ricerca di modelli alternativi, non ritengono in alcun modo credibili al momento le tecnologie decentralizzate basate sulla blockchain.
Uno degli episodi più curiosi a cui abbiamo assistito di recente è stato il lapidario dialogo su Twitter tra Sam Altman, CEO di OpenAI e noto fautore del Web 3.0, e il vulcanico Elon Musk, che lo ha invece apostrofato come “Bullshit”, motivando in seguito al fatto che il Web 3.0 al momento non sarebbe una realtà dotata di grande fondamento, quanto piuttosto una marketing buzzword, con tutte le considerazioni del caso.
Il comportamento di Musk nell’influenzare gli andamenti delle tecnologie è ampiamente noto, per cui non sorprende vederlo denigrare alcuni aspetti che non lo vedono coinvolto più di tanto, dal momento che lo fa anche dove è direttamente interessato, ai fini di ottenere dei vantaggi speculativi. Ne sono la riprova le sue dichiarazioni per influenzare l’andamento di alcune crypto e la condotta che, nel momento in cui scriviamo, sta tenendo nei confronti di Twitter nel bel mezzo della sua acquisizione.
Le critiche nei confronti del Web 3.0 sorprendono infatti maggiormente quando arrivano dal pulpito di Jack Dorsey, già fondatore di Twitter e da sempre aperto alle potenzialità delle blockchain in ambito fintech. Dorsey si è dimostrato particolarmente critico nell’impiego di tecnologie come la blockchain in ambito web, sostenendo in un certo modo incoerente che i suoi principali finanziatori siano gli stessi venture capitalist che sostengono da sempre i business del Web 2.0.
Secondo Dorsey, nessuno potrebbe impedire ai soliti colossi della tecnologia e della finanza di controllare anche le applicazioni del Web 3.0, con le stesse logiche con cui ogni giorno acquisiscono centinaia di startup ed aziende innovative.
Sulla stessa lunghezza d’onda si pone Evgenij Morozov, sociologo bielorusso, specializzato in nuovi media e nello studio degli effetti dello sviluppo tecnologico sui sistemi socio-economici. Particolarmente noto per la sua critica all’internet-centrismo, Morozov sostiene tuttavia che il Web 3.0, nonostante sia fondato su un paradigma decentralizzato, non possa prescindere dal contributo dei grandi player tecnologici e che la sua attuale proposizione sia di fatto un’utopia.
Non si contano i detrattori che rilevano come il Web 3.0 soffra degli stessi limiti delle tecnologie blockchain in materia di sostenibilità tecnologica, economica ed ambientale, quando si parla di una sua implementazione mainstream. Altri rilevano i possibili pericoli dati dall’assenza, in certi ambiti, di una forma di controllo centralizzato, capace di fungere da trust, pur con tutti i pro e i contro del caso.
La democratizzazione di un servizio non corrisponde necessariamente alla sua equità e al fatto di garantire a tutti le stesse opportunità. Il più delle volte il Web 3.0 potrebbe configurare una liberalizzazione che consente ai più abili ed indiscriminati di trarre vantaggio da situazioni che, soprattutto nella novità, presenta moltissime zone grigie in termini di regolamentazione, senza oltretutto potervi porre rimedio, a causa della decentralizzazione stessa del servizio.
Le sfide che il Web 3.0 dovrà superare per diffondere la propria ideologia non si limita all’aspetto tecnologico, ma dovrà soprattutto concentrarsi nel fare in modo che le alternative pratiche che propone rispetto al Web 2.0 non si traducano nel proverbiale passaggio dalla padella alla brace.
Privacy e sicurezza, un problema di non semplice soluzione
Il Web 2.0 si è rivelato spesso molto fragile in termini di protezione dei dati. Praticamente tutti i big tech sono rimasti puntualmente vittime di data breach più o meno estesi, che hanno messo a rischio la privacy di milioni di persone in tutto il mondo, per il semplice fatto di aver condiviso i propri dati personali su Whatsapp, Linkedin e sui data center dei servizi centralizzati più diffusi sul web 2.0.
Il Web 3.0 nasce anche per porre un freno a situazioni di questo genere e la blockchain in teoria sarebbe la tecnologia perfetta per crittografare i dati di traffico sulla rete. Purtroppo si tratta di una tecnologia al momento troppo dispendiosa per pensare di poterla estendere alla mole di dati personali che vengono scambiati sul web ogni giorno. Non è un caso che la tecnologia blockchain sia impiegata con successo nell’ambito delle criptovalute, che prevedono un numero estremamente limitato di transazioni rispetto al complessivo traffico di dati sulla rete.
Qualunque possa essere il punto di vista nei confronti della sicurezza dei dati sul web, una condizione efficace prevede che il prezzo da pagare sia sempre molto alto. Una sicurezza intrinseca, come quella che sarebbe garantita dalla blockchain, al momento non sarebbe in alcun modo sostenibile, se non per applicazioni molto circoscritte, che costituiscono al tempo stesso il punto di partenza per sviluppare l’evoluzione di una tecnologia dal potenziale enorme.
Nel breve termine è plausibile che le applicazioni Web 3.0 dimostrino maggior attenzione nel rispetto della privacy degli utenti finali, consentendo più possibilità di scelta rispetto alle condizioni unilaterali rigidamente imposte dai servizi Web 2.0. Tale approccio non risulta in ogni caso del tutto risolutivo dal punto di vista della sicurezza, complicando anche la gestione delle applicazioni stesse.
Immaginiamo un assistente virtuale. Indubbiamente si tratta di un’applicazione che acquisisce una grande quantità e varietà di dati personali, ma come potrebbe garantire le sue funzionalità agli utenti se avesse accesso soltanto ad una porzione limitata di dati? Trovare la giusta misura è tutt’altro che semplice, soprattutto quando si tratta di automatizzare i servizi.
Un’altra comodità del centralizzato a cui sarebbe difficile rinunciare è quella dell’accesso rapido a molte applicazioni attraverso il nostro account Facebook o Google, che evita tediose procedure di registrazione in cambio della cessione di una grande varietà di dati personali, che possono essere a quel punto acquisite dai nostri account. Dal punto di vista tecnologico, il decentralizzato offrirebbe ad esempio la possibilità di accedere tramite dei wallet, ma si tratta di un’eventualità in ogni caso meno comoda da gestire e che comporta, anche in questo caso, la registrazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli che abitualmente utilizziamo.
La sfida tra il Web 2.0 e il Web 3.0 si giocherà molto anche sul piano della responsabilità dei singoli utenti. La comodità fa pendere il proverbiale ago della bilancia da parte del Web 2.0, mentre la responsabilità tenderebbe a privilegiare le novità del Web 3.0.
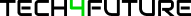





![Particolare di una catena di unità robotiche messe a punto dai ricercatori dell’Università di Amsterdam, ciascuna composta da un rotore posto sopra un motore elettrico [Credit: “An endless domino effect” - Università di Amsterdam - https://www.uva.nl/en/shared-content/subsites/institute-of-physics/en/news/2024/03/an-endless-domino-effect.html].](https://tech4future.info/wp-content/uploads/2024/04/solitoni-topologici-metamateriali-robotici-2024-343x198.webp)


![Fotografia che ritrae, da sinistra, la parte esterna e la parte interna dei guanti per interazioni tattili, con sensori tattili e attuatori vibrotattili (evidenziati dai riquadri) integrati [Credit: “Adaptive tactile interaction transfer via digitally embroidered smart gloves” - Department of Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology - https://www.nature.com/articles/s41467-024-45059-8].](https://tech4future.info/wp-content/uploads/2024/03/guanti-per-interazioni-tattili-finalizzate-apprendimento-343x248.png)
